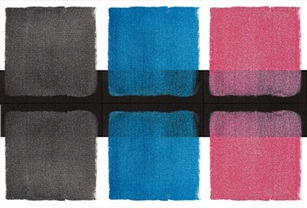@Gaetano Intile
Vedo con piacere che questa discussione sembra ravvivarsi.
Amo il fattore umano nella scrittura, perché a scrivere sono gli uomini, e le donne ovviamente. Personalmente ho sempre voluto ragionare certo sul “perché si scrive”, ma che per me porta anche a chiedersi “chi è che scrive” innanzi tutto, che può avere una sua importanza non sempre relativa.
Intendiamoci: un capolavoro è tale a prescindere da chi l’abbia scritto, che si conoscano o meno gli estremi della sua vita ma per me è importante conoscere la vita, i pensieri, le azioni e i comportamenti dell’autore, per quanto possibile. Conoscendo il contesto storico ci si riesce a calare meglio nell’opera, conoscendo anche qualcosa dell’autore questa “immersione” aumenta, diventa più coinvolgente, si riesce a leggere tra le sue righe.
Io amo, io voglio pormi domande oltre il necessario, oltre la tecnica, da manuale o estemporanea, oltre la bellezza formale di uno scritto, della sua veridicità, della sua attinenza alla realtà sociale, alla sua storicità.
Ad esempio: amo Il nome della Rosa di Umberto Eco, fui uno dei primi ad acquistare la prima edizione che lessi e rilessi con entusiasmo. Sapere che l’autore era ateo e di idee che io potevo anche non condividere mi fece approcciare al testo con una certa prevenzione, ma rimasi affascinato dal testo e in seguito dalla sua trasposizione cinematografica dove la scena finale del giovane monaco Adso che rinuncia all’amore terreno di una donna per seguire la sua vocazione religiosa mi ha sempre commosso. Se un ateo rappresenta una cosa del genere senza disprezzarla o irriderla, anche se forse non la condivide, però la rispetta, merita di essere letto.
Può sembrare una banalità, una fisima pour parler, ma per me è importante.
Cito un altro esempio, che però mi colpì assai negativamente, ammesso che sia vero.
Ho sempre ammirato la scrittura asciutta, essenziale, direi geniale di Ernest Hemingway. Lui asseriva che uno scrittore dovrebbe scrivere soltanto di cose che conosce, che ha vissuto in prima persona. Sono parzialmente d’accordo. Emilio Salgari ha descritto un mondo nei pirati della Malesia senza essere mai stato in quei posti, senza aver mai conosciuto nessuno dei personaggi che descrisse minuziosamente in tutti i loro aspetti sociali e storici, compresi i luoghi dove avevano vissuto, semplicemente documentandosi con cura.
Non è una cosa alla portata di tutti, come lo fu per Hemingway, aver partecipato alla prima Guerra Mondiale, alla Guerra Civile Spagnola, alla seconda Guerra Mondiale, al netto della vita a Parigi negli anni Venti, nella Spagna nell’ambiente delle corride, in Africa con i safari. La materia prima dei suoi romanzi e racconti.
Nel 2006 uscì un articolo nel Corriere della Sera, questo è il link,
articolo è breve e vale la pena di leggerlo. Non posso dire se sia la verità, non ne parla nessuno. Se fosse vero, tirando le somme, Hemingway amava uccidere anche uomini. Si dirà che in guerra lo fanno tutti. In guerra si, contro nemici armati che ti sparano addosso. Non nei casi riportati nell’articolo, desunti da lettere dello stesso Hemingway, se l’articolo riporta notizie vere, visto che è firmato da un giornalista che avrà fatto le sue indagini.
Questo non squalifica Hemingway come scrittore, ma se la notizia è vera c’è da pensare; la sua scrittura, la sua “lezione” assumerebbe un altro significato.
Perdonate la digressione, ma parlando di scrittura si parla anche, necessariamente, di scrittori, della loro vita, del loro contesto sociale.
Si salveranno solo coloro che resisteranno e disobbediranno a oltranza, il resto perirà.
(Apocalisse di S. Giovanni)